
Questo paese sconosciuto
da cui nessun viaggiatore è tornato.
(William Shakespeare)
L’ultimo progetto, raccontato un po’ per gioco un po’ per sfida, Vanni Loriga non è riuscito a realizzarlo.
“Quando compio cento anni scrivo un libro, in quelle pagine ci sarà tutto quello che ho visto nella mia vita”.
Lo diceva a un gruppo di colleghi riunito attorno a lui. Ascoltare Vanni era un piacere, aveva mille storie nel suo archivio, che poi era un cervello capace di fondere matematica ed emozioni. Narrava con la sapienza di uno sceneggiatore di talento. Ogni personaggio era arricchito con aneddoti curiosi, spiritosi, intriganti. La scenografia era sempre curata, dava risalto soprattutto ai dettagli.
È stato (tra le altre mille cose della sua vita) un giornalista, uno scrittore. Apparteneva alla categoria dei fuoriclasse.
Ne parlo al passato, con la tristezza che forse aggiunge un po’ di quella retorica che a lui proprio non piaceva. Ne parlo al passato perché quel libro non ce l’ha fatta neppure a cominciarlo.
Oggi se ne è andato via per sempre. Aveva novantacinque anni.
Me lo ricordo alle 5:15 del mattino, in quell’alba del 25 settembre 1988 che annunciava drammi e vergogna. Lui era nella hall dell’Hilton Hotel dove Ben Johnson aveva riservato quattro suite: per la sua famiglia, per quella del medico Astaphan, per il manager Larry Heidebrecht e per l’allenatore Charlie Francis.
Ben Johnson era l’uomo che il pomeriggio precedente aveva stupito il mondo e portato Vanni a chiedersi sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio “come potessero essere possibili certi improvvisi e miracolosi progressi”.
Un saluto veloce, poi un invito che non prevedeva un rifiuto.
“Si è registrato sotto falso nome. Chiedi il numero di stanza di Joe Benson alla reception. Poi va su e bussa alla porta della sua camera”.
Ovviamente nessuno mi aveva risposto e tantomeno aperto quando avevo bussato alla stanza 1706. Ma a Vanni era difficile dire di no.
Tornato giù riferivo a lui e a Sergio Rizzo, che era il capo spedizione. Vanni continuava a indagare, a chiedere, si infilava in posti dove non avrebbe mai dovuto essere. Era fatto così, interpretava il mestiere senza concedersi alibi o prendere tempo.
Come quando nel 1972, dopo l’assalto dei fedayn alla palazzina degli israeliani durante i Giochi di Monaco, aveva deciso che quella tragedia meritava una testimonianza diretta. A qualsiasi costo.
Così ha raccontato quei momenti sulla rivista TempoSport, nel numero di maggio/giugno 2022.
“Alle prime ore del mattino del 5 settembre il vicedirettore Sergio Neri mi comunica che debbo raggiungere il Villaggio Olimpico perché è stato segnalato un attacco terroristico.
Accorro all’”Olimpisches Dorf” e capisco immediatamente che siamo in clima di guerra. Quella che sino a poche ore prima era un’oasi di pace e di allegra fraternità vive in stato di assedio. Le migliaia di poliziotti che indossavano garbate divise bianche e turchese pastello, gli esageratamente gentilissimi “Olys”, improvvisamente hanno riassunto l’aspetto severissimo della feldgendarmerie.
Nel Villaggio non si entra più, mentre prima c’era praticamente via libera per tutti. C’è una ressa di giornalisti e si apprendono le prime approssimative notizie. Verso le ore 4:30, otto fedayn (il plurale arabo di fida’i, cioè devoto) di Settembre Nero, una cellula di al-Fath (che significa il/la giovane) che fa parte dell’OLP di Yasser Arafat, partiti in taxi alle 3:30 dall’hotel Eden Wolf scavalcano la rete di recinzione del villaggio, aiutati addirittura da atleti statunitensi reduci da festeggiamenti notturni.
Irrompono negli appartamenti israeliani al numero 31 della Connollystrasse ed aprono il fuoco contro Moshe Weinberg e Yosef Gurtfreund che si oppongono, come possono, all’attacco.
Alle 4:47 una donna delle pulizie, che ha sentito gli spari di kalashnikov, lancia l’allarme. Alle ore 5:00 un Oly (un vezzeggiativo diminutivo di Olympia) si reca sul posto. Vede sul balcone un terrorista incappucciato e gli chiede cosa stia succedendo: per tutta risposta vien lanciato sulla strada il cadavere di Yossef Gutfried.
Alle 5:08 i terroristi gettano due fogli di cartone, raccolti da un poliziotto: c’è la richiesta di liberare 243 palestinesi, detenuti in Israele, e alcuni terroristi tedeschi della Rose Armee Fraktion.
I fedayn, che hanno ucciso due israeliani e che ne hanno in ostaggio altri nove, chiedono risposta entro le ore 9, minacciando di uccidere un israeliano per ogni ora di ritardo.
Intanto la folla dei giornalisti aumenta e preme.
Uno urla: “In base alla convenzione di Ginevra abbiamo il diritto di entrare…”. Affermazione che mi pare strampalata: ma si tratta degli stessi colleghi che si erano malignamente lagnati di una occasionale difficoltà ad ottenere il pass: “Era più facile a suo tempo entrare nel lager di Dachau…”.
I tedeschi, che allora cedevano, ora sono inflessibili: ma ho anche il timore che qualcuno possa riuscire a forzare il blocco e con una certa temerarietà dico a me stesso: “Se ne entra uno, quello debbo essere io…”.
Percorro tutta la recinzione del Villaggio: ogni cinque metri c’è una severissima vedetta di guardia. Raggiungo una specie di terrapieno: di là si scorge la palazzina israeliana e si intravede il terrorista con passamontagna, reso famoso dalle riprese tv e dai fotografi. Debbo assolutamente avvicinarmi. Siamo a sei metri di altezza, la polizia tedesca lì non c’è. Faccio un rapido ragionamento: se mi attacco alla balaustra e mi sporgo restano quattro metri; mi lascio andare e con una spinta mi giro e casco a terra, capovolta alla paracadutista e sono dentro… Memorizzo tutti i movimenti, li effettuo…
Risultato finale: cado pesantemente sulla gamba destra, sento uno scricchiolio, temo di essermi slogato la caviglia ed invece vedo il malleolo spuntare dalla calza: frattura esposta di tibia e perone, la mia Olimpiade è finita.
Mi trasportano all’ospedale Bogenhausen, al pronto soccorso una bella dottoressa dai capelli rossi mi riduce manualmente la frattura, vengo operato (48 punti tra esterni ed interni) e dopo due ore sono a letto, ingessato ma con una bella Tv accesa che mi tiene compagnia ed un telefono sul comodino che tornerà prezioso perché ogni tanto mi chiama Eddy Ottoz, nostro collaboratore che da semi clandestino vive nel Villaggio.
I terroristi sono ancora lì…”
Preciso, informato, un resoconto che offre una visione completa della scena, senza alcuna concessione a cadute di stile o scivolate nella retorica. Questo, e molto altro ancora, era Giovanni Maria Loriga, nato a Isili il 2 marzo 1927.
A Roma, il 19 luglio del 1922, se ne è andato via per sempre. È stato un grande. Aveva tutto quello che si dovrebbe chiedere a chiunque voglia fare il nostro mestiere: cultura, curiosità, coraggio, sfrontatezza, rispetto per la notizia, voglia di raccontare.
Ciao Vanni, non sei stato un campione. Caro Maggiore, tu eri un fuoriclasse.
Un simbolico abbraccio da tutti noi, ti abbiamo voluto bene…


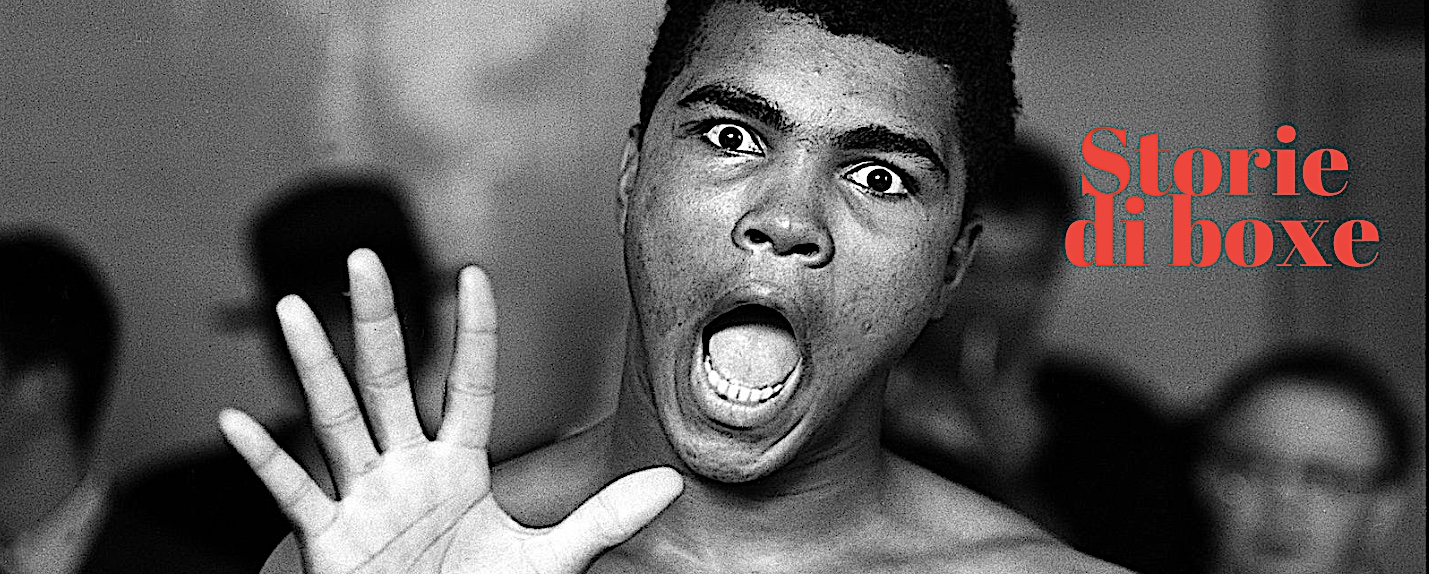

Un pensiero su “È scomparso Vanni Loriga, un fuoriclasse del giornalismo”